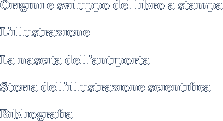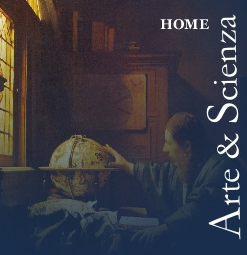
Il
frontespizio si affermò, nell'ultimo decennio del Quattrocento,
nelle forme del titolo breve (occhietto), del titolo con vignetta (la
vignetta serviva a decorare la fronte del libro e, allo stesso tempo,
a dare un'idea immediata del suo contenuto) o dentro cornice; si diffuse,
poi, ampiamente, al principio del secolo successivo e venne accogliendo
alcuni degli elementi che, sino a quel momento, erano stati racchiusi
nel colophon: le indicazioni sull'opera, sull'edizione, sul tipografo
e la marca. L'origine del frontespizio, dunque, fu occasionata da motivi
pratici ed insieme estetici.
Il nuovo aspetto, soprattutto in alcuni tipi di libri, da un canto servì
a dare risalto all'autore, al titolo dell'opera e, più tardi, al
tipografo; dall'altro, acquistò la funzione di richiamo pubblicitario.
Il titolo, in particolare, perse il suo plurisecolare carattere discorsivo
e crebbero i sottotitoli, indicanti particolarità e pregi dell'opera
o dell'edizione.
Gli antichi tipografi, inizialmente, si limitarono ad inscrivere il titolo
in un'ideale forma geometrica (un triangolo, un cono tronco, etc); quando,
poi, avvertirono la necessità di amplificare il richiamo al contenuto
dell'opera, ricorsero all'uso dell'immagine.
A questo momento iniziale seguirono secoli di disordinata evoluzione,
caratterizzata da sconcertanti anticipazioni, contaminazioni e sopravvivenze.
Se il titolo isolato nella prima pagina fu un'acquisizione della nuova
arte, la decorazione della pagina iniziale del testo era consueta già
nel manoscritto, dal quale gli stampatori la derivarono. La molteplicità
di forme che, sin dai primi tempi, venne assumendo il frontespizio (occhietto,
sommario o indice del contenuto, titolo con immagine) era funzionale rispetto
a determinati generi di opere e a speciali esigenze di presentazione,
cosicché ogni libro aveva il suo frontespizio specifico. Diversamente
dalle altre arti figurative, infatti, l'arte tipografica è stata
sempre sottoposta ad una pressione costante, esercitata dal contenuto
del testo e dalle varie esigenze dell'industria libraria sulla forma e
sulla libertà del disegno, venendone, così, condizionata
nello sviluppo.
Il frontespizio tipografico cominciò presto ad accogliere elementi
decorativi, cornice e vignetta, che si trovavano sulla pagina iniziale
e alla fine del volume; li conservò per circa tre secoli e, poi,
li cedette alla copertina.
Generalmente si distinguono due forme di frontespizio decorato: l'una
presenta una cornice che inquadra il titolo, l'altra una leggenda che
comprende un elemento decorativo centrale. In realtà, tale distinzione
risulta troppo rigida, giacché gli elementi sopra elencati possono
combinarsi in modi piuttosto diversi, generando, spesso, soluzioni assolutamente
originali ed inclassificabili. L'evoluzione del rapporto tra titolo e
decorazione, infatti, non obbedì a leggi fisse; la presenza della
decorazione e il suo peso rispetto al titolo variarono a seconda del tempo,
dell'individualità degli artefici, del mutare del gusto e, infine,
dei cambiamenti nella concezione del frontespizio, nel suo insieme.
Durante il primo glorioso periodo di diffusione del frontespizio, cioè
negli anni tra la fine del Quattrocento ed i primi decenni del secolo
successivo, si ebbe un'assoluta originalità creativa; poi, sin
oltre la seconda metà del Cinquecento, accanto a motivi originali,
che arricchirono la vasta tipologia dei frontespizi, si ripeterono stancamente
moduli di repertorio e si riutilizzarono, addirittura, vecchi caratteri
e logori legni, sia interamente sia parzialmente.
Fu l'affermarsi della calcografia e l'intervento di nuovi maestri, spesso
incisori e pittori di fama internazionale, a determinare una ripresa della
decorazione libraria in senso artistico. In tal modo, furono realizzati
frontespizi non solo illustrati, ma anche interamente incisi, e la sostituzione
del rame al legno rese possibile una maggiore sfumatura ed una più
decisa plasticità della decorazione stessa.
La
decorazione del frontespizio cinquecentesco fu caratterizzata da raffigurazioni
sempre più complesse, vistose, spesso ingombranti. Protagonista
assoluta di tale tipo di composizione fu senz'altro la cornice, che si
può distinguere in tre tipi fondamentali: vegetale, istoriata,
architettonica. In essa si combinavano e si contaminavano vicendevolmente
vari elementi, sino ad originare, non di rado, pagine sovraccariche, spesso
prive di una reale inquadratura, che lasciavano ben poco spazio alla leggenda
(dedica, titolo, sottoscrizione). Apparvero, infatti, elementi vegetali
di rinnovato realismo (serti di fiori e frutti, girari di foglie con uccelli,
intrecci di foglie d'acanto, tralci d'alloro e di vite ), portali ed edicole
variamente e riccamente ornati da elementi architettonici (capitelli sempre
più lontani dagli ordini classici, elaborati timpani, lapidi, zoccoli
e paraste), da elementi fantastici (festoni, medaglie, mascheroni, bucrani,
tritoni, sirene e amorini), da statue che affermavano un nuovo stile tridimensionale
(cariatidi e telamoni, serie di piccole scene o scene uniche che si svolgevano
sui quattro margini a scopo illustrativo).
Anche la marca tipografica, collocata di solito al centro del frontespizio,
assunse una maggiore importanza decorativa cedendo al gusto complicato
dell'emblematica. Tra i vari elementi del frontespizio, essa era l'unico
veramente originale, in quanto serviva a differenziare, in modo vistoso,
la produzione di un editore da quella di un altro. Finché fu relegata
nel colophon, fu rappresentata da un unico tipo convenzionale, il cerchio
con la doppia croce e con le iniziali dell'editore, seppur con numerose
varianti (iniziali, fregi e qualche altra semplice figura geometrica).
Accanto a questo tipo ce n'erano altri tre: araldico, allusivo ed emblematico.
Il Cinquecento rappresentò, senza dubbio, il secolo d'oro delle
marche tipografiche; nel Seicento, invece, il trionfo del concettismo
barocco snaturò l'originaria funzione della marca, assoggettandola
al gusto del tempo.
La loro varietà è veramente sorprendente ed impedisce ogni
rigido schema di classificazione; abbiamo, così, marche parlanti
ed allusive (alludono, cioè, al nome dell'editore, al contenuto
del testo, all'autore dell'opera), figure simboliche ed allegoriche, classiche
e mitologiche (come la Sibilla, il Centauro, le sirene, Pegaso). Anche
emblemi religiosi e Santi patroni, fino ad includere celebri episodi dell'Antico
e del Nuovo Testamento, oggetti comuni e strumenti scientifici animavano
lo scenario del frontespizio, palesando analogie davvero sorprendenti
con le altre arti del tempo.
Una qualche relazione con la marca aveva lo stemma, anch'esso inserito
tra titolo e sottoscrizione; poteva appartenere ad un sovrano o ad un
personaggio cui era stata dedicata l'opera o per conto del quale era stata
realizzata la pubblicazione. Anche lo stemma, come la marca, offrì
ben presto il pretesto a numerosissimi motivi ornamentali, spesso a decorazioni
che giunsero ad occupare l'intera pagina del frontespizio (né marca
né stemma, ma insegna è quella riferita ad un'accademia).
Nel corso del tempo, comparvero anche le note a piè di pagina,
comprendenti il nome del tipografo, il luogo e l'anno di edizione; la
menzione del privilegio, con le formule cum privilegio o cum gratia et
privilegio, importante ai fini di una protezione legale dell'edizione;
la licenza di stampa (con licenza de' superiori o superiorum permissu).
Nel
corso del XVII secolo l'evoluzione del frontespizio approdò a soluzioni
particolarmente complesse. Si verificarono casi di doppi frontespizi,
di frontespizi interni per diverse parti dell'opera, di frontespizi sostituiti
o imitati e la difficile convivenza tra titolo e decorazione si risolse
con la nascita di una tavola incisa in antiporta. Nel corso del secolo,
si affermarono definitivamente tre tipi di frontespizi: quello tipografico,
quello con decorazione (con marca, stemma, vignetta, ritratto o cornice)
e quello interamente inciso.
La frequente appariscenza della "facciata" contrastava, in realtà,
con la relativa decadenza del libro secentesco, che presentava spesso
carta scadente, caratteri logori e numerosi errori nel testo, dichiarati
negli errata-corrige. Si attribuiva un'enorme importanza alla parte esteriore
del volume, si intendeva conferire risalto alla sua veste e al momento
della sua presentazione; perciò, la decorazione svolgeva un ruolo
fondamentale. Così, apparvero illustrazioni caratterizzate da estrosità
ed enfasi, antiporte persino più grandi del libro e piegate una
o più volte; i vistosi frontespizi assomigliarono sempre più
agli enormi e sovrabbondanti apparati effimeri, come catafalchi, quarantore,
grandiose macchine funebri ed allegoriche, che si allestivano in tutta
Europa, in occasione delle più svariate celebrazioni.
La sobria e maiestatica frontalità cinquecentesca, che saldava
il titolo e il suo inquadramento decorativo in un'unità architettonica,
si era ormai dissolta. Ai portali ed alle statue allegoriche, inoltre,
si aggiunsero il paesaggio, l'atmosfera, il Sole e le nubi; le composizioni,
si articolarono, spesso, in scene minori, non di rado affastellate. Esse
presentavano giochi prospettici, il digradare e il sovrapporsi di immagini,
con effetti assolutamente inediti, il cui fine era unicamente suscitare
meraviglia e stupore, secondo i dettami della "poetica" secentesca.
I riferimenti alle altre arti, pittura, scultura, architettura e scenografia,
erano piuttosto evidenti un po' ovunque. Persino i titoli delle opere
diventarono enfatici, allegorici, bizzarri, spesso oscuri e prolissi.
Nel
Secolo dei Lumi, l'opulenta decorazione barocca cedette il passo alle
eleganti e delicate soluzioni rococò. Piccole incisioni e stemmi,
talvolta colorati, alleggerirono e semplificarono notevolmente la pagina
destinata ad ospitare il frontespizio; la copertina, che aveva conosciuto
un lontano precedente quattrocentesco, ritornò ad essere realizzata,
nella seconda metà del Settecento, in carta pesante colorata, senza
titolo e adorna di una semplice cornice.
Nel secolo successivo, infine, la copertina, rinata a scopo protettivo
per tanti volumi non meritevoli della costosa legatura, si rese più
utile ed attraente, arricchendosi del titolo, di qualche decorazione e
dell'illustrazione, anche a colori. Il frontespizio tornò, allora,
a ridursi al solo elemento tipografico.