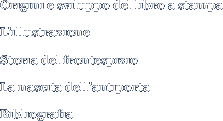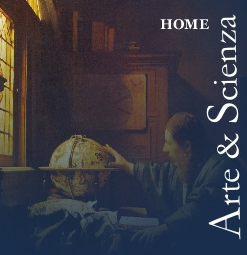
Storia
dell'illustrazione scientifica
-L'immagine
stampata e la diffusione del pensiero scientifico
-Funzione ornamentale ed ermeneutica dell'illustrazione
scientifica
La funzione allegorica
L'immagine stampata e la diffusione del pensiero scientifico
Tra l'ultimo quarto del Cinquecento
ed i primi anni del secolo successivo l'Europa assistette alla nascita
del libro scientifico illustrato. In esso l'immagine veniva utilizzata
per la schedatura metodica di fenomeni scientifici e di innumerevoli aspetti
della realtà naturale, distinguendosi per sistematicità
e naturalezza sempre crescenti.
Una classificazione di tipo enciclopedico veniva realizzata mediante il
disegno e la stampa coniugati con la tecnica, sempre più raffinata,
dell'incisione su rame. Questa modalità conoscitiva e di catalogazione
dello scibile attraverso l'immagine era particolarmente sollecitata dalle
corti europee (dalla corte medicea in Toscana e da quella rudolfina a
Vienna e a Praga), dalle Università, sia quelle di antica fondazione
sia quelle nate sulla scia del risveglio culturale, scientifico e religioso
del Rinascimento, sempre più frequentate da studiosi e studenti
di ambito internazionale. Riceveva, infine, nuovi impulsi anche dagli
amatori-collezionisti.
Con l'intensificazione della produzione a stampa dei libri di carattere
scientifico, che prevedeva anche la pubblicazione di testi divulgativi
di discipline tecniche e di saperi molto settoriali e a volte marginali
(tra il XVI il XVII secolo, i manuali di equitazione, di scalcheria, di
pirotecnica, di scacchistica, i testi che illustravano la costruzione
di orologi e di strumenti musicali, gli almanacchi corredati da tavole
astronomiche ed astrologiche pervenivano ad un pubblico piuttosto vasto
di lettori grazie ai costi contenuti, al numero elevato di tirature e
all'incremento della percentuale delle illustrazioni. La loro ampia diffusione
editoriale era consentita anche dai circuiti di vendita subalterni, quali
raduni fieristici e commercio ambulante), emergeva una diffusa consapevolezza
circa la necessità di favorire, mediante il diretto raccordo tra
scritto ed immagine, una comprensione più immediata dei procedimenti,
dei meccanismi e dei fenomeni delle scienze. Si proponeva, perciò,
un corredo iconografico incisivo e preciso, rispondente a nuove esigenze
di realismo mimetico.
Tre le funzioni peculiari svolte dall'illustrazione scientifica: ornamentale,
ermeneutica, allegorica.
Funzione ornamentale ed ermeneutica dell'illustrazione scientifica
Una
delle principali funzioni svolte dall'apparato iconografico consistette
nell'offrire al lettore del tempo una descrizione ed una spiegazione del
contenuto scientifico del testo (funzione ermeneutica), altrimenti comprensibile
solo agli "esperti". Tale compito descrittivo favorì
senz'altro l'avanzamento e il progresso delle scienze naturali, diffondendo
copie figurative del tutto corrispondenti alle stesse descrizioni biologiche,
anatomiche e botaniche. In tal modo, nelle illustrazioni degli atlanti
e dei trattati di storia naturale, l'esplorazione e lo studio della natura
trovarono uno strumento formidabile per la presentazione e la divulgazione
dei risultati delle ricerche, spostando l'asse della scienza dall'approccio
erudito a quello sperimentale. In campo astronomico, tale ruolo è
stato rivestito dagli atlanti celesti, nonché dalle numerose rappresentazioni
della Luna e dei pianeti.
L'illustrazione scientifica, dunque, venne configurandosi, sempre più,
come un veicolo di informazioni autonomo, concorrenziale e, in alcuni
casi, più potente del testo verbale; essa realizzò un linguaggio
non parlato, una sorta di istruttore silenzioso, in grado di liberare
la letteratura tecnica dalle difficoltà semantiche o puramente
linguistiche.
L'altro importante compito assolto dall'illustrazione scientifica fu quello
ornamentale, ereditato dalla plurisecolare consuetudine di illustrare
e decorare con miniature i testi di alcuni manoscritti, quali trattati
di medicina e di astrologia, erbari, lapidari e bestiari, dove scrittura,
decorazione e pittura si presentavano intimamente legati. Tuttavia, tale
importante tradizione si era avviata verso un lento, ma inesorabile declino,
già sul finire del Quattrocento.
Tra il XVI e il XVII secolo, nei libri a stampa, comparvero frontespizi
caratterizzati da composizioni sempre più complesse, ritratti più
o meno verosimiglianti e capilettera parlanti, basati sul principio degli
antichi alfabeti visivi, ed antiporte ricchissime, dove il riferimento
all'opera diventava addirittura occasionale. Essi costituivano i principali
elementi cui era affidata l'attrattiva anche del libro scientifico, che
generalmente si presentava al suo interno, soprattutto nel caso dei trattati
di astronomia e di matematica, come una serie di tabelle e di dati scarsamente
invitanti, eccezion fatta per i dotti. Tale ornamentazione, inoltre, era
indispensabile affinché l'opera riuscisse più gradita al
dedicatario e mecenate, quasi sempre di origine aristocratica e solo di
rado in possesso di conoscenze di carattere scientifico, e impreziosita
dal punto di vista del suo valore estetico.
Solo più tardi, cioè a partire dalla fine del Settecento
e per tutto il corso del secolo successivo, una nuova serie di progressi
tecnici, relativi alla riproduzione delle immagini, in particolare lo
sviluppo della litografia e della fotografia, privò la decorazione
e l'illustrazione della forza creativa che le aveva caratterizzate nei
secoli precedenti. Tali progressi contribuirono, inoltre, a dissolvere
la dimensione "artigianale" del prodotto illustrativo, annullando
anche quel fondamentale rapporto di collaborazione e di interazione tra
l'autore del testo e l'incisore.
L'illustrazione dei testi, infatti, era realizzata o da veri e propri
artisti o dagli autori stessi o mediante la collaborazione di più
specialisti.
Gli artisti che "servirono" l'illustrazione scientifica nel
corso dei secoli, furono numerosi ed alcuni assai celebri. Per citarne
i più noti, Joris Hoefnagel ed il veronese Jacopo Ligozzi si distinsero
per ciò che concerneva le raffigurazioni di elementi botanici e
zoologici; Leonardo, Michelangelo, Cellini, Vincenzo Danti e Alessandro
Allori relativamente all'anatomia scientifica; Albrecht Dürer, cui
si deve, tra le altre opere, la rappresentazione di due splendidi emisferi
celesti con le relative costellazioni (Norimberga, 1515), e l'estroso
artista di corte, Stefano della Bella, incisore della celebre antiporta
della prima edizione del Dialogo galileiano, per quanto riguardava l'illustrazione
astronomica (G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,
tolemaico e copernicano, Firenze, per i tipi di Giovan Battista Landini,
1632). Per le opere scientifiche di autori ancora in vita, è legittimo
supporre la collaborazione di questi con i maestri incisori, allorché
l'illustrazione e la decorazione alludessero al contenuto delle opere.
D'altra parte, i rapporti tra autore, disegnatore, incisore e stampatore
non furono sempre facili e testimonianze di ciò sono ampiamente
rintracciabili in epistolari e in fonti di vario genere (si veda, per
esempio, il dibattito relativo all'allestimento del frontespizio per l'edizione
bolognese secentesca delle opere galileiane). In molti altri casi, non
sempre corroborati dalla necessaria documentazione, gli autori dei testi
si trasformarono anche in ideatori e, addirittura, in disegnatori ed incisori
degli apparati iconografici, che corredavano le loro opere. A tal proposito,
esempi estremamente significativi ci sono offerti dall'attività
incisoria di Francesco Fontana, per il suo Novae Coelestium terrestriumque
rerum observationes, e dall'indispensabile collaborazione del padre gesuita
Athanasio Kircher con i disegnatori e gli incisori delle sue complesse
ideazioni emblematico-allegoriche. Esemplare è anche il caso offerto
delle Tabulae Rudolphinae (J. Keplero,Tabulae Rudolphinae, Ulm, typis
J. Saurii, 1627) di Keplero, così intitolate in onore dell'imperatore
Rodolfo II, protettore di Tycho Brahe. Questi, infatti, morì senza
aver portato a termine il lavoro intrapreso e Keplero continuò
l'opera lasciata interrotta dal suo illustre maestro, cui era succeduto
nel ruolo di matematico cesareo. Per questo trattato, l'ultimo pubblicato
durante la sua vita, egli contribuì alla realizzazione delle tavole
dei pianeti e ideò l'antiporta, un trionfo dell'allegoria barocca,
incisa dal norimberghese Georg Celer. Il prezioso bozzetto dell'astronomo,
che presenta numerose differenze rispetto alla versione definitiva dell'incisione,
è oggi conservato presso l'Archiv der Kepler-Kommission di Monaco.
Per quest'opera, ritenuto da alcuni storici dell'astronomia uno dei veicoli
fondamentali per la diffusione del pensiero di Keplero, il celebre astronomo
secentesco ideò un tempio di Urania, a base ottagonale, simbolo
del sapere astronomico, sormontato da sette figure femminili corredate
da vari strumenti scientifici, personificazioni allegoriche di discipline
scientifiche. Nella versione definitiva incisa dal Celer, il tempio presenta
una base decagonale e si arricchisce di dettagli figurativi assenti nel
disegno realizzato da Keplero.
L'immagine
stampata si è ben presto trasformata nel più efficace mezzo
di trasmissione - da parte degli autori dei testi, degli incisori e dei
tipografi - e di ricezione di idee e di teorie ritenute pericolose, o
forse soltanto "scomode", dalle autorità politiche ed
ecclesiastiche. Tale ruolo poté essere svolto dalle illustrazioni
dei testi attraverso la funzione allegorica.
L'allegoria, che si colloca tra la funzione ornamentale e quella ermeneutica,
era volta a compendiare il testo o alcune delle sue parti per via iconologica.
La valenza allegorica delle immagini era un elemento determinante nel
rapporto tra autore e pubblico: i lettori erano ben disposti a diffidare
di ciò che l'immagine, di primo acchito, mostrava loro, mentre
erano pronti a carpire ciò che la medesima intendeva realmente
rappresentare. Diventava, dunque, molto importante conoscere l'immaginario
cui si riferivano le illustrazioni, già al momento della loro realizzazione.
In tal caso, un aiuto essenziale era (e lo è ancora oggi per gli
studiosi) offerto da un certo numero di repertori e di trattati, che contribuivano
notevolmente non solo ad identificare e a riconoscere simboli ed allegorie,
ma anche a sollecitare la fantasia degli artisti, originando una sorta
di "codice interpretativo", comune sia al lettore sia all'illustratore
(tra le opere basilari per l'interpretazione delle figurazioni ricordiamo
l'Iconologia di Cesare Ripa, pubblicata per la prima volta a Roma, nel
1593, senza immagini e, poi, nel 1603, ancora nella capitale papale, in
edizione illustrata; l'Emblematum Liber del giurista milanese Andrea Alciati,
pubblicato in edizione illustrata nel 1531; gli Hieroglyphica dell'erudito
romano G. Valeriano Pierio, pubblicati a Basilea nel 1505; gli Hyerogliphica
di Horus Apollo, o Horapollo, originati da un manoscritto del V secolo
d. C. scoperto nel 1419 da un monaco sull'isola greca di Andros, e editi
per i caratteri aldini nel 1505).
La valenza allegorica delle immagini assume aspetti davvero interessanti
se pensiamo al sostanziale contributo offerto dal corredo iconografico
di molte opere alla diffusione del pensiero scientifico. Un caso emblematico
in tal senso è dato dai trattati di astronomia (intesa come "nuova"
astronomia) e cosmologia stampati negli anni più duri della censura
(secoli XVI e XVII). Vediamo come.
Dopo secoli di supremazia incontrastata, il plurisecolare Universo geo-antropocentrico,
a partire dalla prima metà del Cinquecento, cominciò ad
essere seriamente minato dall'elaborazione di nuove cosmologie che rischiavano
di frantumare la grandiosa macchina celeste teorizzata da Aristotele prima
e da Tolomeo più tardi. Gli ostacoli allo sviluppo e alla diffusione
della nuova visione prospettica del cosmo, proposta da Copernico (Universo
eliocentrico) e variamente rielaborata da Tycho Brahe (crisi dell'incorruttibilità
e dell'immutabilità dei cieli), Giovanni Keplero (Sole come centro
architettonico e centro dinamico del cosmo), Giordano Bruno (infinità
dell'universo; pluralità dei mondi e loro abitabilità; identità
di struttura tra cielo e Terra), Galileo Galilei (invenzione del cannocchiale
ottico; numerose scoperte scientifiche a sostegno dell'universo eliocentrico)
ed Isaac Newton (coerente sistemazione, sul piano del metodo e su quello
delle soluzioni, della rivoluzione scientifica), infatti, minacciava di
intaccare seriamente la massima autorità filosofico-scientifica
del passato (Aristotele) e, soprattutto, di distruggere l'apparato dogmatico
della Cristianità occidentale (Creazione, Ascensione, Incarnazione
e Redenzione) mettendo in dubbio la parola di Dio (numerosi i passi delle
Sacre Scritture in cui è evidente il presupposto geocentrico: ad
esempio, nell'Ecclesiaste 1, 4-5 si legge: "Una generazione va e
una generazione viene / eppure la Terra rimane sempre al suo posto";
nel Libro di Giosuè 10-12 si trovano le celebri parole: "Fermati,
o Sole, su Gabaon e tu, Luna, sulla valle di Aialon!" e nel Libro
dei Salmi è scritto: "Sulle sue basi fondasti la Terra / e
starà immota negli evi degli evi"). L'attacco alla tradizione,
quindi, non comportava esclusivamente l'abbandono del principio, così
fortemente radicato nel senso comune e nell'opinione dei dotti, dell'immobilità
della Terra e della sua centralità nell'Universo, ma tentava anche
di separare le verità di fede, affermate dalle Sacre Scritture,
da quelle ricavate dallo studio della natura. Per tali motivi la Chiesa
si oppose tenacemente alla distruzione dei dogmi minacciati dalle dottrine
rivoluzionarie, facendo ricorso a provvedimenti che colpissero con durezza
qualsiasi forma di circolazione delle nuove idee. Queste disposizioni
portarono ben presto all'istituzione di potenti organi di controllo anche
sulla stampa e sul commercio dei libri; d'altro canto, le norme repressive
erano rivolte sia ai testi in latino sia a quelli in volgare, dai trattati
alle missive, senza particolari distinguo tipologici. Ciononostante, le
numerose teorie "sovversive" continuarono a serpeggiare in tutta
l'Europa, sia cattolica sia protestante. In tal senso le immagini stampate
dovettero svolgere un ruolo di grande rilievo, grazie alla facilità
di circolazione e, quindi, di penetrazione capillare, che le caratterizzava
rispetto ad altri tipi di manufatti, riuscendo ad eludere meglio i sospetti
degli organi di sorveglianza e di censura sulla stampa (l'insieme delle
immagini stampate, ricco o povero che fosse, risultava infatti di difficile
valutazione).
Il progresso scientifico, in conclusione, ha trovato nelle immagini un
indispensabile elemento di continuità, soprattutto nei momenti
in cui il testo verbale ha dovuto necessariamente arrestarsi dinanzi ai
dogmi della tradizione.
Una riflessione di questo tipo può fornire elementi indispensabili
per la comprensione del ricorso, spesso eccessivo ma solo apparentemente
immotivato, da parte di incisori e tipografi a pagine sovraccariche di
simboli, emblemi e figurazioni allegoriche non di rado di difficile interpretazione.