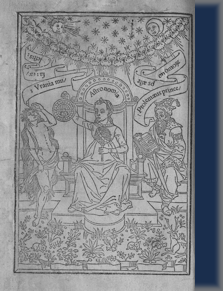cliccare sull'immagine per ingrandirla
Venezia,
1488
I. Sacrobusto
supporto
cartaceo
oggetto: tavola silografica
incisione silografica
20x14
L'opera del Sacrobosco: un classico della letteratura astronomica medioevale
L'edizione
veneziana del De sphaera mundi di Giovanni Sacrobosco, datata 28
(o 30) febbraio 1488 (come si evince dal colophon), si apre con una tavola
silografica, realizzata presumibilmente nello stesso periodo in cui fu
stampato l'incunabolo.
Incisa sul verso della prima carta, secondo il principio di estetica grafica
dell'apertura (opening), l'immagine è priva di legenda (dedica,
titolo e sottoscrizione) e di informazioni relative al testo. Per tale
motivo, essa non costituisce il frontespizio dell'opera, che cominciava
ad affermarsi lentamente proprio sul finire del Quattrocento; rappresenta,
piuttosto, una straordinaria anticipazione dell'antiporta secentesca.
La xilografia, infatti, costituisce un'attraente "facciata"
per il prodotto tipografico e, al contempo, traduce in immagine il contenuto
di carattere astronomico del testo. Tali esigenze, sempre più avvertite
dai tipografi e dagli editori, furono soddisfatte, a partire dai primi
anni Seicento, dall'illustrazione in antiporta.
Le notizie relative all'edizione tipografica del libro sono conservate
nel colophon. E' interessante scorrere le poche
righe stampate sul recto dell'ultima carta, dove lo stampatore, che non
si cita affatto, accanto all'anno e al luogo di stampa dell'opera, saluta
con entusiasmo la recentissima invenzione tedesca dell'arte tipografica:
"Anche questo singolare opuscolo di scienza astrale è stato
pubblicato per mezzo di quella magnifica arte ultimamente divulgata dall'ingegno
germanico e cioè con la stampa tipografica. Il giorno prima delle
calende di aprile. Nell'anno 1488. A Venezia" (Hoc quoquae sideralis
scientiae singulare opusculum / mirifica illa arte nuper ingenio germanico
/ in luce prodita impressione videlicet / Prididie calen. Aprilis. Anno
Salutis MCCCCLXXXVIII. Venetiis).
Invoca, poi, Urania, Musa dell'Astronomia, alle quale dedica un carme:
"Versi di lode impressi su questa piccola opera. O Urania per quanto
ammettono di doverti, tutti gli abitanti di Canopo: gli astri scoperti…da
Giovanni proveniente dalla città di Santritter…le forme così
devono [essere] scoperte per te. Né meno di questo devono
a te tra i Santi Girolamo. Questi ti associo: infatti questo li trova
e tu li dividi" (Carmina in impressorum huic opusculi laude. Uranie
quantu quantu debere fatentur, cuncta canopeo: cognita quae astra viro
/ Santritter helbronna lucili ex urbe Iohannes / Schemata sic debent ipsa
reperta tibi / Naec minus haec tibi de Sanctis hieronyme debent / Quam
socio: namquae hic invenit ipse secas).
I riferimenti all'antico Egitto (Canopo era una città del Basso
Egitto, sulla foce occidentale del Nilo e per metonimia indica anche Basso
Egitto o Egitto) e a Iohannes, senza dubbio Giovanni Sacrobosco,
autore dell'opera, descrivono qui un'ideale parabola che accomuna addirittura
Tolomeo, nato probabilmente a Tolemaide d'Egitto nel II secolo d. C.,
all'astronomo e matematico inglese, sancendone l'autorevole posizione
nell'ambito dell'astronomia, e facendolo definire "scopritore di
astri". In realtà, il Sacrobosco non scoprì mai nuovi
corpi celesti, ma di sicuro fu uno dei maggiori studiosi di Tolomeo e
dei suoi commentatori arabi del XIII secolo, soprattutto Al-Battani e
Al-Farhani.
Il De sphaera mundi, l'opera cui è maggiormente legata la
fama del canonico agostiniano, compendia il celebre testo tolemaico (Almagestum)
e si divide in quattro capitoli. Il capitolo I definisce la Terra come
una sfera immobile, posta al centro del firmamento, secondo il sistema
tolemaico-aristotelico; nel capitolo II, sono spiegati i vari circoli,
equinoziale, celestiale, il primum mobile, l'eclittica dello zodiaco,
etc.. Il capitolo III si conclude con una discussione sui sette climi;
il movimento del Sole e dei pianeti allora conosciuti, le cause delle
eclissi lunari e solari, formano il capitolo IV. L'opera ottenne un grande
successo, godendo di una fama che lo rese un classico dell'astronomia
fino alla fine del 1600; spesso apparve sotto forma di commento, a cura
dei più eminenti scienziati del XIV, del XV, del XVI e del XVII
secolo, tra cui si ricordata almeno la versione realizzata da Cristophoro
Clavio nel 1570.
Dopo l'Astronomica di Manilius, infine, la Sfera fu il primo
libro di contenuto astronomico ad essere dato alle stampe (G. Sacrobosco,
De Sphaera Mundi, Ferrarae, 1472).
Per tornare alla tavola silografica, essa presenta un'iconografia chiara,
che allude evidentemente al contenuto del testo: l'allegoria dell'Astronomia,
una giovane donna abbigliata secondo la moda rinascimentale, è
assisa in trono, stringe nella mano sinistra una sfera armillare e con
la mano destra sembra protendere un antico astrolabio verso Urania (l'Astronomia
- un tempo non disgiunta dall'Astrologia - ha per attributo, dai tempi
di Marziano Capella in poi, il globo; suo attributo specifico è
il sestante, usato in origine per misurare l'altezza degli astri; talvolta
ha tra i suoi strumenti la sfera armillare). La Musa, posta sulla destra
dell'Astronomia, è rappresentata in scala metrica minore rispetto
agli altri due protagonisti della scena: coperta appena da un drappo succinto
e col capo coronato d'alloro, dal corpo privo di rilevanti particolari
anatomici, rivolge il suo sguardo verso l'alto, portandosi una mano agli
occhi come per proteggerli dalla luce del sole. Dal capo della donna seminuda,
inoltre, si snoda un cartiglio che reca la scritta "Urania Musa Caelestis".
A sinistra dell'Astronomia, invece, compare la figura di Tolomeo. Anche
in questo caso, il solito cartiglio ci permette di fugare ogni dubbio
relativo all'identità della figura senile e barbuta: "Ptolomeus
Princeps Astronomorum". L'astronomo alessandrino è abbigliato
come un mago orientale, in quanto magia e scienza costituivano un intreccio
ancora difficilmente districabile, presenta una corona adagiata sul capo,
ad indicare che è princeps o rex astronomorum, e tiene aperte sulle
ginocchia le pagine di un libro, su cui si intravedono alcune figure geometriche.
Il libro, probabilmente il suo Almagestum, allude all'atteggiamento teorico
nei confronti dell'astronomia, in contrapposizione a quello di Urania,
simbolo di un atteggiamento più incline alla pratica osservativa.
Ai piedi dei tre illustri personaggi, si apre un'amena vegetazione popolata
di piccoli animali, cervi, conigli e lucertole, che sembrano muoversi
indisturbati. Nella parte superiore, invece, è rappresentata la
volta celeste, trapunta di piccole stelle simili ad asterischi, che si
dispiega tra il Sole e la Luna. Il primo presenta il volto di un fanciullo,
che irradia luce, e la seconda il volto di una giovane donna, che sembra
rivolgere uno sguardo benigno alla Terra.
L'intera composizione è racchiusa in una semplice cornice fortemente
stilizzata.
Le figure dinoccolate, disegnate ed incise a grandi tratti, sono animate
da una rozza vivacità. E' assente, inoltre, la ricerca di giochi
d'ombra e di luce. Ancora concepita per determinare una fantasiosa decorazione
in superficie, la composizione è estremamente ricca dal punto di
vista naturalistico e del costume; ma dedica scarsa attenzione al dato
prospettico, presentando figure appena scalate in profondità. Dobbiamo
ricordare che, invece, l'incisione e la pittura erano già da tempo
avviate ad esaltare la plasticità della figura umana e a riprodurre
uno spazio misurabile in profondità, organizzato secondo le leggi
della prospettiva.
I riferimenti all'arte nordica, fiamminga in particolare, sono piuttosto
evidenti: il microcosmo di animali e vegetali si coniuga al macrocosmo
rappresentato dagli elementi celesti (Sole, Luna, stelle), attraverso
un naturalismo ancora estraneo alla cultura figurativa italiana della
fine del Quattrocento. Il fatto che l'opera sia stata stampata a Venezia
non deve dissuaderci dall'ipotesi di una possibile attribuzione dell'anonima
silografia ad un maestro d'oltralpe; infatti, fu anzitutto la Germania,
patria dell'arte tipografica e di una fiorente industria silografica,
che adottò la consuetudine di illustrare con silografie ogni tipo
di libro. Intanto, sul finire del Quattrocento, molti incisori e tipografi
tedeschi lasciarono il proprio Paese per andare ad esercitare il "mestiere"
altrove, soprattutto in Italia; nel fare ciò, essi portarono con
sé legni incisi o ne incisero di nuovi, così che le silografie
dei primi libri stampati in Europa risultano essere spesso di fattura
tedesca o fiamminga.
L'intera composizione, infine, ricorda l'impaginazione della tavola centrale
di un polittico quattrocentesco, cui si ispira anche dal punto di vista
iconografico; infatti, le straordinarie Sacre Conversazioni con Madonna
assisa in trono col Bambino e i Santi, che hanno fortemente caratterizzato
la pittura sacra del Quattrocento e del Cinquecento, hanno costituito
senza dubbio un precedente iconografico fondamentale per la nostra tavola
(il motivo della Madonna in trono, col Bambino e i santi, costituisce
uno dei soggetti iconografici più diffusi nella pittura del Quattrocento
e del Cinquecento. Splendidi esempi a tal proposito ci sono offerti da
artisti come Filippo Lippi - Pala Barbadori, 1438-, Domenico Veneziano
- Pala di Santa Lucia de' Magnoli, 1445-1447 -, Andrea del Castagno
- Madonna di Casa Pazzi, 1445 -, Giovanni Santi - Madonna, santi
e committente, 1489 -, Lorenzo di Credi - Madonna e santi,
1485 -, Cosmè Tura - Pala Roverella, 1470-1474 - , e tanti
altri).