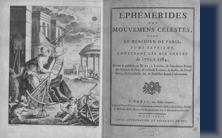cliccare sull'immagine per ingrandirla
Parigi, 1774
M. De La Lande
supporto
cartaceo
oggetto: antiporta
incisione calcografica
30x19
L'antiporta
delle Éphémérides des mouvemens célestes,
pour le méridien de Paris, tome septieme, contenant les dix années
de 1775 à 1784, pubblicate a Parigi nel 1774, fu disegnata
dal parigino Simon Challe (1719-1765)
e incisa da François Antoine Aveline,
probabilmente negli anni sessanta del Settecento, per il volume delle
Éphémérides di Nicolas Louis de La Caille
(N. L. La Caille, Éphémérides des mouvemens célestes,
pour dix années, depuis 1765 jusqu'en 1775, et pour le meridien
de la ville de Paris, a Paris, des caractères & de l'Imprimerie
de Jean-Thomas Herissant, 1763). La stessa composizione, infatti,
introduce il testo parigino del 1763.
L'illustrazione, che allude al contenuto di carattere astronomico del
testo, si dispiega lungo l'intera pagina. Essa presenta, in primo piano,
la figura di una giovane donna, dal volto sereno, con i seni scoperti
e col capo coronato da una stella; è Urania, Musa dell'astronomia,
fasciata da una veste trapunta di stelle, detta ortostadia, con
voce greca che designa la tunica dritta, e attorniata da putti che sembrano
divertirsi a giocare con telescopi, quadranti mobili, orologi e squadre.
La figura di Urania conferisce un'espansione diagonale alla composizione,
enfatizzata anche dai numerosi strumenti astronomici rivolti verso la
medesima direzione. La Musa indica, con la mano sinistra, un'eclisse di
sole ben visibile nel cielo, mentre con l'altra mano invita lo sguardo
del lettore-fruitore verso le pagine aperte di un libro, su cui è
riprodotto il titolo dell'opera del de la Lande. Alle sue spalle, si riconosce
la torre di un osservatorio, la Specola parigina, dalla quale viene fuori
un telescopio puntato verso il Sole, già in parte oscurato dall'astro
lunare. Sulla destra della composizione, in lontananza, si scorge un tempietto
circolare, dove tre uomini, abbigliati come antichi filosofi, discutono
probabilmente del raro fenomeno astronomico che si sta consumando in quegli
istanti. All'interno del tempio, memore delle architetture rinascimentali,
un giovane, ancora abbigliato alla maniera antica, si china verso un globo
celeste (?).
L'immagine dei philosophes, in particolare, ricorda l'incisione
in antiporta del Dialogo dei Massimi Sistemi del mondo, che, realizzata
nel 1634 da Stefano della Bella, recupera il modulo iconografico dei Tre
filosofi giorgioneshi (Giorgione, Tre filosofi, 1508; Vienna,
Kunsthistorisches Museum), con la rappresentazione dei tre "eroi"
delle scoperte astronomiche, cioè i celebri Tolomeo, Aristotele
e Copernico.
La parte centrale della composizione, invece, palesa i suoi legami con
la pittura tardo barocca francese, evocando le suggestive soluzioni stilistiche
e figurative adottate da alcuni artisti attivi in Francia tra la fine
del Seicento ed i primi decenni del secolo successivo, come François
Boucher. Si veda, in particolare, la tela dal titolo Rinaldo
e Armida (F. Boucher, Rinaldo e Armida, 1734, olio su tela;
Parigi, Louvre) dove sono notevoli le affinità tra la figura di
Armida e la Musa in antiporta.
La dolcezza, di cui è investito il volto della Musa, ed il modo
sapiente con cui sono trattati i panneggi, a tratti scultorei, come sulle
ginocchia, a tratti morbidi, come sul drappo che ricopre il busto, si
accompagnano alla sensualità nella posa e ad un'ottima resa dell'anatomia
del corpo femminile, accentuata qui dall'uso di sapienti soluzioni chiaroscurali.
Caratteristiche molto simili si riscontrano nella figura dell'eroina del
Boucher, che presenta un volto aggraziato e levigate forme anatomiche
ed è accompagnata, come nella nostra incisione, da numerosi putti,
pigramente distesi ai suoi piedi. Anche gli edifici architettonici, l'Osservatorio
di Parigi, nell'opera di Challe, e le antiche costruzioni romane, nella
tela di Boucher, si sviluppano lungo la medesima direttrice spaziale,
fungendo, in entrambi i casi, quasi da quinta teatrale rispetto ai gruppi
centrali. E' probabile, dunque, che Simon Challe conobbe l'opera del pittore
ed incisore parigino e ne offrì, poi, un'interpretazione grafica
piuttosto fedele.