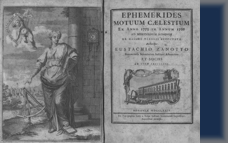cliccare sull'immagine per ingrandirla
Bologna, 1774
E. Zanotti
supporto
cartaceo
oggetto: antiporta
incisione calcografica
26x18
L'antiporta
delle Éphémérides motuum coelestium ex Anno 1775
in Annum 1786 ad meridianum Bononiae ex Halleii tabulis supputatae,
di Eustachio Zanotti, fu ideata da Anton
Maria Zanetti ed incisa da Bernard Picart, presumibilmente negli anni
settanta del XVII secolo.
L'intera composizione riflette la poliedrica personalità artistica
dello Zanetti. Caratterizzata da un rigore formale, lontano dalle scenografiche
soluzioni secentesche, essa palesa, infatti, la presenza di elementi figurativi
di matrice eterogenea. La figura femminile che affiora in primo piano,
caratterizzata da un recupero in senso classicistico, è circondata
da diversi strumenti scientifici, quali l'orologio, il compasso ed il
quadrante mobile. Il corpo imponente della donna si accompagna ad un volto
di straordinaria grazia; il contorno della figura, inoltre, è netto
e senza interruzione ed il "contrapposto" studiato è
molto convincente. La gamba sulla quale scarica il peso del corpo, l'altra
gamba, la linea inclinata delle spalle ed il dolce movimento della testa,
infatti, sono ben equilibrati e sostenuti dal vestito e dal mantello che
cadono. Le pieghe voluttuose delle vesti, infine, sono raccolte sul fianco
sinistro, lievemente sporgente. Il riferimento alla statuaria antica,
dunque, sembra essere piuttosto evidente.
L'artista veneziano fu un grande conoscitore della scultura classica,
cui dedicò, in collaborazione col cugino Girolamo, un'edizione
illustrata dal titolo Delle antiche statue greche e romane, edita
in due volumi nel 1740 e nel 1743. Per le illustrazioni che corredarono
il testo fu egli stesso a fornire i disegni da incidere. Tale opera si
inseriva nel solco di quel filone di studi orientati verso la ripresa
di modelli desunti dall'antichità greca e romana che, sulla scia
dell'entusiasmo suscitato anche dai recenti scavi di Ercolano prima (1738)
e di Pompei più tardi (1748), proliferarono lungo l'intero arco
del Settecento.
Il punto di vista fortemente scorciato del carnoso putto, che sembra poggiare
il piede sinistro su un piano virtuale, mentre regge uno svolazzante cartiglio,
tradisce l'impianto classicistico della rappresentazione, conferendole
un dinamismo che funge da "contrappunto" alla staticità
dell'insieme. E' qui evidente il legame con il linguaggio figurativo tardo
barocco, che l'artista potrebbe avere in parte "recuperato",
attingendo all'opera pittorica di Carlo Maratta, e piegato alle esigenze
di fini espressivi assolutamente nuovi.
Come già accennato precedentemente, lo Zanetti fu anche pittore
dilettante, educato presso la bottega del veneziano Niccolò Bambini.
Quest'ultimo condivise proprio col Maratta un lungo soggiorno romano dove,
probabilmente, ebbe la possibilità di assimilare alcune delle sue
geniali soluzioni figurative, contrassegnate da un eclettico classicismo,
nel quale anche gli stimoli dell'ultimo barocco secentesco si componevano
in uno stile corretto e solenne.
E' dunque possibile che alcuni degli elementi peculiari della pittura
marattesca fossero, poi, giunti allo Zanetti, filtrati proprio attraverso
la personalità artistica del suo maestro.
Di certo il Maratta non fu l'unico artista secentesco a far uso di angeli
e putti, che giocano con ghirlande di fiori o si affacciano con vispa
curiosità attraverso uno squarcio di nuvola. Egli, però,
ne fece quasi un elemento distintivo, un leit-motiv che accomunò
un buon numero delle sue opere.
Per tornare alla nostra antiporta, sul fondo della composizione si apre
un paesaggio, in cui si scorge la città di Bologna, riconoscibile
dalle due Torri, quella degli Asinelli e quella di Garisenda. Tale sfondo,
per le sue caratteristiche "atmosferiche", accentuate dai forti
contrasti chiaroscurali di matrice pittorica, sembra evocare le suggestioni
della straordinaria tradizione pittorica veneta, avviata da Giorgione
da Castelfranco verso un rinnovato interesse per le soluzioni naturalistiche
e diversamente interpretata, poi, da celebri artisti come Tiziano, Sebastiano
del Piombo, Tintoretto, Veronese e Jacopo Bassano. D'altro canto, Zanetti
studiò con attenzione tutti questi grandi maestri del Cinquecento
e ad essi dedicò alcune opere letterarie di notevole interesse,
come una raccolta del 1771, Della pittura veneziana e delle opere pubbliche
dei veneziani maestri, ma soprattutto la raccolta delle Varie pitture
a fresco de' principali maestri veneziani ora per la prima volta con le
stampe pubblicate del 1760, costituita da ventiquattro tavole, da
lui disegnate ed incise all'acquaforte e a bulino ne 1755.