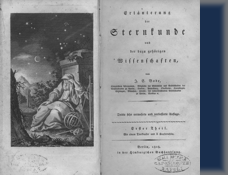cliccare sull'immagine per ingrandirla
supporto
cartaceo
oggetto: antiporta
incisione calcografica
20x11
Una splendida
antiporta ottocentesca precede, sul verso della prima carta, il frontespizio
dell'opera di Johann Elert Bode, Erlauterung Der Sternsunde, pubblicata
a Berlino, nel 1808, presso l'editore Nimbugschen Buch Handlung.
Nelle prime pagine del testo, l'autore ci fornisce una preziosa spiegazione
(1) della complessa rappresentazione in antiporta, permettendo
di comprenderne appieno il significato.
L'enigmatica figura in primo piano, un vecchio barbuto, seduto ai piedi
di un basamento marmoreo, trae palesemente origine da un plurisecolare
soggetto iconografico, di cui il celebre maestro di Norimberga, Albrecht
Dürer, ci offrì una straordinaria interpretazione nella sua
Melanconia I (incisione, 1514). La figura
del melanconico, variamente interpretata nel corso dei secoli (si veda,
per esempio, la figura di Eraclito nella Scuola di Atene di Raffaello,
1509-1511; Roma, Palazzo Vaticano, Stanza della Segnatura), si trasforma
qui in un antico filosofo greco, come lo definisce lo stesso Bode; il
tradizionale motivo della mano mollemente appoggiata alla guancia, un
antichissimo gesto riferibile solitamente al dolore, alla fatica, ma anche
al pensiero creativo, alla contemplazione profetica di poeti, filosofi,
evangelisti e padri della Chiesa, si accompagna al viso in penombra, con
lo sguardo fisso davanti a sé. Gli strumenti scientifici, come
la sfera armillare, il triquetrum, il compasso goniometrico, la meridiana
orizzontale equinoziale, la tavola su cui sono rappresentati i percorsi
eccentrici dei pianeti, le stelle che si stagliano nel cielo e l'eclisse
di Luna sono tutti simboli di un'occupazione di tipo astronomico. Il rotolo,
che si dispiega sulle ginocchia della figura senile, su cui si riconosce
la rappresentazione di un'eclisse di Luna e la sovrapposta schematizzazione
del metodo di Eratostene, rappresenta il fine intellettuale unificante,
che accomuna la grande varietà di strumenti sopra elencati. Su
uno dei lati del basamento, privo di statua o colonna, compare un serpente
che si morde la coda: quest'ultimo allude all'infinità e all'eternità
della "scienza delle stelle". Sul fondo della composizione,
si erge il Monte Olimpo, alle spalle del quale sta per sorgere il Sole;
il chiarore dell'alba illumina il profilo maestoso del celebre monte e
rischiara l'orizzonte mattutino della Grecia. Nel cielo, infine, sono
riconoscibili alcune costellazioni, quali le stelle del Toro, dell'Auriga,
dei Gemelli e di Orione, e la posizione esatta di certi astri: il Sole
sta entrando nel Leone, Giove si trova sotto le Pleiadi, la Luna è
ad est rispetto alle corna del Toro e Venere appare alla sinistra della
Luna.
L'incisione è firmata da Johann Gottlob
Shumann.
Dall'analisi stilistica della rappresentazione in antiporta affiorano
numerosi elementi che palesano l'adesione alle tendenze pittoriche più
aggiornate dei primi anni dell'Ottocento. Schumann dovette carpire le
"punte" più avanzate della sperimentazione artistico-figurativa
condotta da alcuni pittori del suo tempo. Basti pensare che Dresda (città
d'origine dell'incisore), in quegli anni, era non solo una città
ricca di tesori d'arte e sede della più importante Accademia tedesca,
ma anche un "laboratorio" di sperimentazioni artistico-figurative,
condensatesi principalmente nell'opera pittorica di Caspar David Friedrich
(1774-1840). Quest'ultimo si trasferì nella nota città della
Sassonia nel 1798; qui elesse a dimora un atelier con vista sull'Elba,
frequentato da numerosi artisti e filosofi del tempo, da cui non si mosse
più, se non per escursioni nella natura o periodici ritorni a Greifswald,
la sua città natale. E' appunto tale riflessione che ci permette
di comprendere alcuni degli aspetti più innovativi espressi dall'incisione
di Schumann.
Nell'antiporta, i numerosi riferimenti alla Grecia classica e la presenza
del basamento marmoreo non riflettono certo il gusto neoclassico, affermatosi
autorevolmente già dalla seconda metà del Settecento; infatti,
tali elementi figurativi, al di là della valenza allegorica che
esprimono, sono inseriti in un contesto che è ben lontano da quell'ideale
di "nobile semplicità e quieta grandezza", indicato da
Winckelmann come espressione della superiorità dell'arte antica,
volto a ricreare l'idea di perfezione classica mediante citazioni e variazioni
di brani di scultura romana, affreschi di Ercolano e dipinti di Raffaello.
Nella nostra composizione, il riferimento all'antico sembra assimilabile,
piuttosto, alla dimensione quasi nostalgica espressa dal vasto complesso
di acqueforti di Giovan Battista Piranesi, dedicato alle Antichità
Romane e dominato da un ricercato e drammatico isolamento (Le incisioni
di Giovan Battista Piranesi ,1720-1778, dedicate alle Antichità
Romane, raccolte in quattro volumi editi nel 1756; nel 1748 era stata
pubblicata una prima versione di Antichità Romane de' tempi della
Repubblica e de' primi imperatori e le successive dedicate al Campo Marzio
dell'antica Roma , del 1762, appaiono legate all'idea di "dignità
e magnificenza romana", espressa attraverso la massa, la grandiosità,
l'isolamento. Piranesi aggiunse "nuove dimensioni" alle rovine
di Roma, grazie ad una precisa scelta degli scorci e ad un consapevole
uso delle luci e delle ombre).
Il basamento marmoreo in penombra domina la parte destra della composizione
ed assume il profilo di una rovina ormai invasa dalla vegetazione, che
sembra, a sua volta, voler cancellare le tracce di un passato irrimediabilmente
perduto. La figura dell'antico filosofo affiora in primo piano e, intersecandosi
con il profilo del monte sacro agli dei dell'antica Grecia, conferisce
un'espansione diagonale alla composizione, che pertanto non è più
concepita in termini statici e descrittivi.
Lo straordinario naturalismo della rappresentazione, inoltre, intriso
di suggestioni quasi fiabesche, fa già pensare a quella pittura
di paesaggio intesa come nuova espressione del sentimento che, sovvertendo
i parametri della tradizionale pittura di paesaggio, affermatasi tra gli
ultimi anni del Settecento ed i primi decenni dell'Ottocento, testimonia
il progressivo affermarsi di una nuova sensibilità, postasi come
valida alternativa al razionalismo dominante. Elementi propri di tale
"sensibilità", definita romantica già nel corso
dell'Ottocento, appaiono il rilievo dato alla creatività e all'interiorità
e, sul piano figurativo, si traducono nel conseguente rifiuto delle norme
sancite dall'Accademia, delle composizioni levigate e anonime, delle forme
simboliche e allegoriche, fondate sull'"impersonale" codice
espressivo classico.
Nella composizione in antiporta, realizzata da Schumann, dominano i principi
della nuova dimensione lirica del paesaggio; il tema del notturno e della
contemplazione, ricorrente nelle opere di alcuni artisti della prima metà
dell'Ottocento - del già citato Friedrich (si veda, per esempio,
la tela dal titolo Due uomini davanti alla Luna,
1819; Dresda, Gemäldegalerie), ma anche di John Constable (1776-1837)
e William Turner (1775-1851) - come un nostalgico refrain si accompagna
ad una visione che ha ormai abbandonato il culto artificiale dell'antichità
del Neoclassicismo e quel vedutismo idealizzato e compiacente, che coniugava
felicemente passato e presente.
(1) Dall'originale
in tedesco: "Un antico filosofo greco, riflette seduto davanti ad
un basamento di colonna, eseguendo un disegno sul problema di calcolare
la distanza del sole dalle eclissi lunari. Alcuni strumenti astronomici
del suo tempo: sono mostrati da un lato il triquetrum, un'asta dritta,
accompagnata da due righetti mobili, con la quale Tolomeo tentava di determinare
la parallasse della Luna; l'astrolabio, ovvero alcuni anelli composti,
per la misurazione dei gradi dei cerchi celesti; un anello solare; una
tavola che mostra i percorsi eccentrici dei pianeti, secondo le idee di
quel tempo. A poca distanza, è posizionato uno gnomone, ovvero
l'indicatore del Sole, con l'aiuto del quale gli antichi trovarono, per
la prima volta, le ore del giorno attraverso l'ombra. Il basamento è
simbolo di infinità e rappresenta la fondazione e l'eternità
della scienza siderale. Dietro all'alto Olimpo, risale il crepuscolo del
mattino. Al firmamento si offrono le stelle dell'Auriga, del Toro, dei
Gemelli e di Orione. Nella loro posizione del tempo di allora, in fondo
all'orizzonte mattutino della Grecia, quando il sole entra nel Leone,
Giove si trova sotto le sette stelle [Pleiadi], la Luna, appena prima
di divenire nuova, è ad est rispetto alle corna del Toro, la stella
del mattino, Venere, appare alla sinistra della Luna.