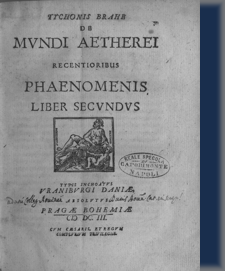cliccare sull'immagine per ingrandirla
DE
MUNDI AETHEREI RECENTIORIBUS PHAENOMENIS LIBER SECUNDUS
supporto
cartaceo
oggetto: frontespizio
incisione silografica
23x17
Il
De mundi aetherei recentioribus phaenomenis liber secundus presenta
una singolare silografia, in verità piuttosto rozza, a decorare la parte
centrale della fronte del libro. Si tratta di una marca tipografica, che
esprime un'accentuata valenza emblematica, ed, inoltre, comprende elementi
figurativi che tradizionalmente esulano da qualsiasi tipologia offerta
dalle varie marche; proprio per tali motivi essa può essere definita una
vera e propria vignetta emblematica. Presenta la figura di un uomo barbuto,
forse lo stesso Tycho, con il capo coronato d'alloro, disteso su una roccia.
L'uomo rivolge il proprio sguardo verso il cielo, simbolo di un atteggiamento
incline alla pratica osservativa, e con la mano sinistra impugna un compasso
appoggiato su un globo celeste retto da un fanciullo (espressione del
binomio osservazione-misurazione). La figura è accompagnata dal motto
"SUSPICIENDO DESPICIO", le cui due parole sono disposte fra loro in maniera
speculare; esso, probabilmente, si riferisce alle doti di osservatore
del cielo, paziente ed acutissimo, del grande astronomo danese. E' singolare
il fatto che, nel colophon dello stesso volume,
si ripeta la vignetta del frontespizio; sono, però, subentrate delle notevoli
variazioni. Rispetto a quest'ultima, infatti, le dimensioni della stampa
sono aumentate, fatto piuttosto strano se si pensa che il colophon, con
l'avvento del frontespizio, aveva ormai perso ogni valore. Lo sguardo
dell'uomo, inoltre, sembra ora sconfinare dai limiti della silografia,
per incontrare gli occhi del lettore-fruitore dell'opera; un serpente,
simbolo di Esculapio, è avvinghiato intorno al braccio destro; la mano
destra regge un fascio di fiori e di spighe. Ai piedi dell'uomo, infine,
lo stesso fanciullo, che regge il globo celeste nell'immagine posta al
centro del frontespizio, sembra qui intento a giocare con alambicchi,
pinze ed oggetti di non chiara identificazione, forse un'allusione a tutte
le scienze e all'interesse di Ticone per l'alchimia. Il motto iniziale
si è invertito e trasformato in "Despiciendo suspicio". Per comprendere
meglio il significato dei due motti, conviene ricomporli idealmente, trasformandoli
in "Suspiciendo in caelum] despicio [terram]", e viceversa (sui due verbi
e sulla loro valenza semantica è possibile fare una approfondita analisi
dal punto di vista filologico. Questa ipotesi è suggerita dal fatto che
essi furono usati già insieme da alcuni autori dell'antichità classica
e che potrebbero corrispondere alla prima parte di un esametro). A questo
punto, dunque, otteniamo che "guardando in alto (cioè alzando gli occhi
verso il cielo), guardo in basso (cioè volgo lo sguardo alla terra)",
e di contro, "guardando dall'alto in basso, guardo verso l'alto". Non
a caso lo sguardo della figura maschile, nel frontespizio, è indirizzato
verso il cielo, dunque in contemplazione dell'universo; invece, nell'immagine
offerta dal colophon, l'uomo guarda addirittura dritto verso di sé, presumibilmente
nell'intento di cercare gli occhi del lettore, elevato, in quel momento
a simbolo del nostro pianeta. L'allusione all'affinità tra gli eventi
celesti e i fenomeni terrestri, fermamente sostenuta dall'astronomo danese,
sembra essere piuttosto chiara. Le due silografie, dunque, veicolano un
significato tutt'altro che trascurabile; la loro collocazione all'interno
del libro (frontespizio-colophon) determina, infatti, un'ideale parabola
del contenuto del testo che, esordendo con l'attacco al millenario sistema
tolemaico e a quello più recente proposto da Copernico, si conclude con
l'affermazione del sistema del mondo proprio del suo autore. Tycho non
crede che alla pigra Terra possa essere attribuito alcun movimento o addirittura
tre, come sostiene Copernico. Se essa fosse in moto, afferma, una pietra
lanciata da una torre non cadrebbe, come invece avviene, ai piedi della
stessa. Il sistema copernicano, inoltre, si oppone alle Sacre Scritture
che fanno più volte riferimento all'immobilità del pianeta terrestre.
Senza impelagarci in discorsi più propriamente scientifici, nel sistema
cosmologico elaborato dall'astronomo danese, la Terra è immobile al centro
di un universo racchiuso da una sfera stellare, la cui rotazione quotidiana
dà conto dei circoli giornalieri delle stelle. Secondo Tycho, le teorie
avanzate da Copernico nel corso del Quattrocento partirebbero, dunque,
da un assunto fuorviante: la mobilità della Terra, determinata in base
alle osservazioni del cielo, (espressa dall'immagine del frontespizio)
non troverebbe corrispondenza in ciò che accade realmente sul nostro pianeta.
Di contro, solo partendo dall'attento studio dei fenomeni terrestri, si
potranno determinare i parametri di riferimento del nostro universo. Idea
perfettamente esemplificata dal soggetto della silografia stagliata al
centro del colophon. La grandissima autorità di Brahe costituì senza dubbio
un ostacolo alla diffusione del copernicanesimo. Ma i problemi che la
sua astronomia aveva sollevato, favorirono la crisi e il graduale abbandono
del sistema tolemaico.