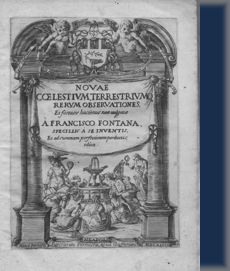cliccare sull'immagine per ingrandirla
supporto
cartaceo
oggetto: frontespizio
incisione calcografica
21x14
La
pagina introduttiva dell'opera dell'astronomo napoletano Francesco Fontana,
Novae coelestium, terrestriumque rerum observationes, si presenta
inserita in una pregevole cornice architettonica.
Il testo, dato alle stampe nel febbraio del 1646, presso la tipografia
napoletana dei Gaffaro (situata in San Biagio Maggiore) risulta di particolare
interesse per una ricostruzione dello stato delle ricerche e delle esperienze
scientifiche a Napoli, intorno alla metà del XVII secolo.
La prefazione dell'autore offriva alcune importanti informazioni sulla
circolazione dei testi scientifici nel Regno e presentava spunti polemici
nei confronti di Galileo Galilei, circa il primato relativo alla costruzione
del telescopio, rivendicato dallo stesso Fontana; infatti, nel frontespizio
della sua opera si legge: "specillis a se inventis". Lo strumento
astronomico fu realizzato, secondo lo scienziato partenopeo, sulle basi
teoriche dellaportiane, nel 1608. Significativa, in tal senso, la notizia,
riportata da Lorenzo Crasso, di alcuni tentativi falliti del Fontana di
venire in possesso dei "fragmenti de gli ordigni lasciati dopo la
morte di Giovan Battista della Porta", cioè dopo il 1615,
evidentemente per fornirsi di strumenti ed attrezzi per l'avvio della
sua attività di costruttore di lenti che, iniziata in quegli anni,
lo rese ben presto rinomato negli ambienti scientifici di gran parte d'Europa.
Numerose testimonianze del tempo confermarono la sua fama di abile artigiano
di lenti per telescopi. E' datata, infatti, 30 novembre 1629 una lettera
di Fabio Colonna, indirizzata a Federico Cesi, in cui troviamo la prima
notizia documentata della costruzione da parte del Fontana del cannocchiale
a lenti convesse: "Il sig. Francesco Fontana…ha fatto un cannone
di otto palmi, con il quale se ben allo rovescio fa vedere la luna et
stelle…" (da Il carteggio linceo della vecchia accademia
di F. Cesi); inoltre, nel 1634, Athanasio Kircher citava il Fontana,
nella sua Ars Magna Lucis et Umbrae (Roma, 1646; Amsterdam, 1671)
come eccellente costruttore di telescopi (dal Carteggio kircheriano).
In una lettera del 6 febbraio del 1644, scritta da Evangelista Torricelli
a Raffaele Margiotti, una lente per telescopi costruita dal Fontana veniva
definita "…il meglio che sia stato fatto tra mille vetri nello
spazio di 30 anni" (da Le opere dei discepoli di Galileo Galilei.
Carteggio 1642-48).
Per avvalorare l'affermazione del suo presunto primato, relativo all'originalità
del telescopio, il Fontana riportava in apertura della sua opera una dichiarazione
del gesuita Gerolamo Sirsale che, intorno al 1625, avrebbe visto, assieme
a Giovan Battista Zupi, il microscopio e il telescopio in casa sua; giustificava
anche la pubblicazione del suo testo, adducendone a motivo le pressioni
degli amici, tra le quali è presumibile fossero particolarmente
insistenti, almeno durante gli ultimi anni della sua vita, quelle di Fabio
Colonna (studioso del mondo vegetale e di quello animale, spesso autore
non solo dei testi, ma anche dalle illustrazioni da cui questi ultimi
erano compendiati), legato all'autore da una lunga comunanza di studi
e di ricerche. Ma, in realtà, Fontana desiderava soprattutto evitare
i plagi, non di rado originati dai ritardi nelle pubblicazioni.
L'opera era suddivisa in otto trattati ed esponeva i risultati delle osservazioni
ottenute al microscopio e al telescopio dall'autore; questi realizzò
personalmente i ventisei rami e le altrettante silografie, che costituivano
il corredo iconografico del libro. Per Fontana, la necessità di
cimentarsi nel disegno e nell'incisione si imponeva ai fini di un'efficace
resa mimetica, che difficilmente avrebbe potuto essere ben realizzata
da chi non avesse effettuato personalmente i rilevamenti telescopici.
A tal proposito, l'autore si scusava con i lettori di non possedere l'abilità
degli incisori fiamminghi, anche se aveva già dato prova delle
sue capacità di disegnatore, illustrando i risultati di alcune
osservazioni al microscopio per il Persio tradotto (Roma, 1630)
dell'accademico linceo Francesco Stelluti e per il Carteggio del Colonna.
Le incisioni in rame, inserite nel testo delle Observationes, riproducono
la superficie lunare, vista attraverso il
cannocchiale astronomico nella successione delle sue fasi, con l'indicazione
della data e dell'ora delle osservazioni in didascalia; per la posizione
e le orbite dei pianeti, invece, il Fontana preferì ricorrere alle
matrici in legno, capaci di garantire un tratto nitido e, al contempo,
dei netti contrasti.
L'opera, attesa dagli ambienti scientifici come portatrice di una radicale
svolta nell'astronomia, deluse gran parte delle aspettative per l'assenza
di un organico apparato di argomentazioni e per la superficialità
delle osservazioni; mancava infatti qualsiasi teoria ottica che desse
fondamento scientifico al funzionamento del telescopio e del microscopio,
ed il tutto si riduceva ad una mera descrizione tecnica (ad esempio, l'astronomo
gesuita Giovan Battista Riccioli nel 1651, pur riconoscendo la qualità
degli strumenti costruiti dal Fontana, prese le distanze dalla maggior
parte delle "novità" da lui osservate)..
Il frontespizio dell'opera è dominato dal portale con timpano curvilineo
spezzato, che funge da degno ingresso all'opera di contenuto astronomico.
Nella parte superiore due putti alati reggono uno stemma coronato da una
croce poliloba e da un cappello cardinalizio; stemma e copricapo si riferiscono
al dedicatario dell'opera, il cardinale Camillo Pamphili. I putti, inoltre,
svolgono un lungo cartiglio, su cui sono riportate alcune parole desunte
da un versetto dell'Antico Testamento: "Quis enarrabit coelorum rationem"
(da Giobbe, 38:…conosci tu le leggi del cielo / o regoli tu il
suo influsso sulla Terra?), ed il verso 4 del Salmo 146: "Qui
numerat multitudinem stellarum, et omnibus eis nomina vocat" (Egli
conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome). Il salmo,
nella versione italiana, è il 147, v. 4. La versione latina lo
divide in due, v. 1-11, 12-20, facendone il 146 ed il 147 della sua numerazione
e rimettendosi in pari con la numerazione dell'ebraico.
Entrambi di contenuto astronomico, intendevano probabilmente confermare
l'inscindibile legame tra le verità di fede, "dettata"
dalle Sacre Scritture, e quelle ricavate dallo studio della natura,
in considerazione del fatto che esso era minato, in quegli anni, dalle
"sovversive" teorie bruniane e galileiane. A tal proposito,
è possibile che il Fontana abbia volutamente preso le distanze
da Galilei, morto quattro anni prima della pubblicazione delle Observationes,
e dalla sua celebre lotta per la separazione fra le verità della
fede e quelle ricavate dallo studio della natura, che lo aveva portato
addirittura a ricercare la conferma delle verità della nuova scienza
nelle Sacre Scritture. Non dimentichiamo che l'astronomo partenopeo
fu amico di numerosi gesuiti come Girolamo Sirsale, Giovan Battista Zupi
e Giovan Giacomo Staserio, quest'ultimo fiero oppositore della scuola
galileiana.
Il tema della piccolezza dell'uomo, insito sia nel salmo sia nel passo
di Giobbe, inoltre, potrebbe costituire un implicito e molto velato richiamo
alla rivoluzione scientifica. Tale piccolezza dell'uomo nella natura e
nell'Universo ribadita dai filosofi "rivoluzionari", infatti,
concorderebbe con la piccolezza dell'uomo rispetto a Dio ed alla natura
da lui creata, sottolineata anche nell'Antico Testamento. In Giobbe
38 viene esaudito il desiderio espresso dal profeta di discutere direttamente
con Dio. La risposta che Dio dà è grandiosa ed in tutto
degna della sua maestà; il problema del dolore non viene risolto
direttamente, ma inquadrato in una serie vastissima di altri problemi,
più complessi ed insolubili per l'uomo. La conclusione che ne scaturisce
è che Colui che conosce perfettamente la soluzione di tanti problemi,
che lasciano stupito e meravigliato l'uomo, non ignorerà certamente
quella del dolore umano. Perciò l'uomo è insipiente quando
si ribella a Dio e lo taccia di malgoverno del mondo, dal momento che
la sua mente piccola si annega in un intrigo insolubile di problemi e
di questioni fisiche, metafisiche e morali. Il discorso si può
dividere in tre parti: v. 1-38, meraviglie della natura inanimata; v.
39 ss., meraviglie della vita animale e contrasto con la piccolezza dell'uomo;
salmo 40, v. 1-5, effetti che la vista di tanta gloria produce su Giobbe.
Per ciò che concerne il salmo 146, gli ultimi cinque salmi del
salterio cominciano con alleluia (= lodate Iahve) [146-147-148-149-150]
e costituiscono un gruppetto omogeneo, che è chiamato "il
piccolo Hallel" (= lode). Nel salmo 146 (v. 5-10) è cantata
la sconfinata potenza di Dio di fronte all'uomo impotente. Egli ha creato
e domina sovranamente tutto ciò che esiste; egli mantiene infallibilmente
le promesse di misericordia ed è il raddrizzatore dei torti fatti
ai deboli. Salmo 147 (nella versione latina 146 composto dai versi 1-11).
Soggetto del primo quadro del salmo, v. 1-11, è il Dio pietoso
e consolatore; Dio è il medico pietoso che guarisce e fascia le
piaghe della sua nazione. Il pietoso consolatore è anche il Dio
sublime, che ha creato l'universo, che ha disseminato per gli spazi celesti
le stelle secondo il numero prestabilito e regola i loro moti, chiamandole
per il suo nome. Nei v. 7-11 dalla grandezza di Dio si sviluppa il Tema
della Provvidenza, che dà cibo e vita a tutti, mediante una sapientissima
organizzazione del mondo. Nei v. 12-20 (versione latina salmo 147) si
dice che attraverso il cosmo la parola di Dio corre rapida come i messaggeri
del re, a far eseguire il mandato divino. Egli comanda, ed ecco a bianche
falde lanose scendere la neve; la brina diffondersi bianca e lieve come
cenere; grandinare il ghiaccio a schegge; la natura irrigidirsi e sospendere
l'opera della vegetazione. Anche nel salmo 146, il primo del gruppo, c'è
un netto contrasto tra la potenza di Dio e la vanità degli uomini.
L'uomo, anche se è un principe, non dispone di scampo, non ha possibilità
di far evadere dai mali e dalla morte. Lo stesso concetto è espresso
nel salmo 147; Dio onnipotente e sapientissimo è il consolatore
degli umili e solo l'empietà ostinata non trova misericordia presso
di Lui.
Il motivo cinquecentesco del frontespizio architettonico a portale viene
qui alleggerito del suo carattere monumentale, per far spazio a soluzioni
di maggiore dinamismo. Esse sono ricche di richiami non solo all'architettura,
legata a schemi compositivi tipicamente secenteschi, ma soprattutto al
teatro. L'elemento architettonico del timpano curvilineo spezzato (tipicamente
cinquecentesco), infatti, si arricchisce di soluzioni ascrivibili alla
corrente barocca: la sintesi di scultura e architettura, la tendenza all'ambiguità
visiva e alla teatralità rappresentano alcuni degli aspetti peculiari
del Barocco. I carnosi putti posti al centro del timpano, comodamente
adagiati sulla trabeazione, coniugano idealmente, attraverso le loro ali
spiegate, le due volute timpaniche ed appaiono incuriositi dalla scena
che si apre nella parte sottostante. Il motivo delle statue, collocate
tra le volute del timpano, ricorre con una notevole frequenza nell'ideazione
di portali di palazzi, chiese e cappelle, ma anche in scenografiche pareti
d'altare, e riscontra un notevole successo nel corso del XVII secolo,
soprattutto tra Napoli e Roma. Il drappo che si dispiega tra le due colonne
corinzie, su cui sono stampati il titolo prolisso e le informazioni relative
all'autore, è posto in sostituzione della tradizionale lapide e,
soprattutto, garantisce alla composizione un sicuro effetto scenografico,
di impatto teatrale. Il "sipario", alzato all'imperiale, scopre
un ideale palcoscenico su cui si muovono numerose figure femminili; esse
sono disposte in modo da creare una sorta di triangolo, alla cui base
corrisponde una fontana (che allude al nome dell'autore: quest'ultimo
è ricorso all'araldica per figurare nella composizione).
Le donne, accompagnate da alcuni attributi iconografici e da esplicite
attribuzioni, stampate su fasce che ne cingono i fianchi e le spalle,
potrebbero rappresentare le personificazioni allegoriche delle discipline
costituenti il Sistema delle arti tardo rinascimentale, in cui
risulta forte il nesso tra arte, scienza e tecnica. La presenza di tale
sistema, nella pagina iniziale del libro, troverebbe una giustificazione
nell'allusione alla pratica astronomica e all'attività di incisore
dello stesso autore. Nel contesto, rappresentato dal frontespizio, dunque,
ogni disciplina trova la sua giusta collocazione rispetto alle altre:
la prospettiva ha il preciso compito di determinare le regole tecniche,
per mezzo delle quali costruire un disegno esatto, quando siano dati l'oggetto
e la posizione dell'occhio; essa necessita, inoltre, di una buona conoscenza
della geometria e della matematica. Di quest'ultima si riconosce non solo
il valore filosofico astratto, in quanto espressione della divina armonia
dell'universo, ausilio indispensabile di numerose discipline, come la
cosmografia, ed oggetto di studio della filosofia, ma anche l'apporto
essenziale alla stessa creatività artistica. L'astronomia, nell'ambito
dell'interconnessione generale dei fenomeni, trova la propria ragione
d'essere nello studio delle influenze esercitate dagli astri sulle vicende
e sulle attività umane. L'armonia universale, infine, è
esemplificata attraverso gli strumenti musicali, alcuni degli innumerevoli
attribuiti della poesia (l'autore del frontespizio, infatti, ricorre all'allegoria
della poesia accompagnata dagli strumenti musicali e non a quella che
la ritrae in compagnia di tre fanciulli, che rappresentano le …tre
maniere principali di poetare, cioè Pastorale, Lirico &
Heroico).
E' evidente che qui l'ideatore dell'opera abbia fatto ampio uso dell'Iconologia
di Cesare Ripa, riproponendo fedelmente gli attributi che il noto perugino
aveva assegnato alle allegorie del suo prodigioso repertorio. Nel nostro
frontespizio, infatti, la Geometria reca con sé un triangolo
ed un compasso: "Donna, che tenga in una mano un perpendicolo, e
con l'altra un compasso: nel perpendicolo si rappresenta il moto, il tempo,
& la gravezza dei corpi: nel compasso la linea, la superficie, &
la profondità, nelle quali consiste il general suggetto della Geometria".
La Matematica, una giovane donna
alata, regge con la mano sinistra un globo terrestre, su cui sono rappresentate
le ore ed i cerchi celesti e con la mano destra impugna un compasso, col
quale descrive una circonferenza su una tavoletta sostenuta da un putto:
"…il compasso è l'instromento proprio, & proportionato
di questa professione, & mostra che ella di tutte le cose dà
la proportione, la regola, & la misura. La palla con la descrittione
della terra, & con le zone Celesti, danno inditio, che la terra nel
misurar delle quali si va scambievolmente, non haverebbono prove, se non
di poco momento, quando non si sostentassero, & difendessero con le
ragioni matematiche. Il fanciullo, che sostiene la tavola, & attende
per capir le dimostrative ragioni, c'insegna, che non si deve differire
la cognitione di questi principij à altra età, che nella
puerile…". La Cosmografia è intenta a descrivere
una figura geometrica per mezzo di un compasso; la
Poesia è coronata d'alloro ed è accompagnata
da alcuni strumenti musicali: "Donna vestita del color del cielo,
nella sinistra mano tenga una Lira, & con la destra il Plettro, sarà
coronata d'alloro…". La Filosofia
è posta al centro dell'ideale emiciclo, di spalle, indossa un vestito
strappato in più punti e regge un libro: "Donna giovane, e
bella, in atto d'haver gran pensieri, ricoperta con un vestimento stracciato
in diverse parti, talché n'apparisca la carne ignuda in molti luoghi,
conforme al verso del Petrarca usurpato dalla plebe, che dice Povera,
e nuda vai Filosofia". L'Architettura tiene fra le mani alcuni
strumenti per la misurazione, quali il filo a piombo, la squadra e l'asta
graduata. L'Astrologia (l'Astronomia - un tempo non disgiunta dall'Astrologia
- ha per attributo, dai tempi di Marziano Capella in poi, il globo. Come
la Geometria, può essere raffigurata in atto di misurarlo con un
compasso; suo attributo specifico è il sestante, usato in origine
per misurare l'altezza degli astri; talvolta ha tra i suoi strumenti la
sfera armillare. Gli stessi attributi di questa figura allegorica competono
anche ad Urania, Musa dell'Astronomia), intesa evidentemente come astrologia
sferica (1), è una figura alata, coronata di stelle, che
indossa una veste stellata e reca con sé un globo celeste ed un
libro aperto, su cui sono rappresentati i simboli di alcuni pianeti. "Donna
vestita di color ceruleo. Avrà le ali agli omeri. Nella destra
mano terrà un Compasso, e nella sinistra un Globo Celeste. Vestiti
di color ceruleo, per dimostrare, che questa scienza è posta nella
contemplazione de' Corpi Celesti. Se la dipinge il Globo Celeste col Compasso,
per essere proprio il suo misurare…agli omeri avrà le ali,
per dimostrare che ella sta sempre col pensiero elevato in alto, per sapere
ed intendere le cose celesti" (la corona di stelle e la veste stellata
sono attributi che di norma caratterizzano la figura di Urania; il libro,
simboleggia l'atteggiamento teorico nei confronti dell'astronomia). La
Prospettiva, infine, regge con la mano destra uno specchio, da cui
emerge un volto riflesso, e con la sinistra un libro sul quale si intravede
la scritta Ptolomoei: "Donna di bellissimo viso, & gratioso
aspetto…tenga con la destra mano, Compasso, Riga, con Squadra, un
Piombo pendente, & uno specchio, & la sinistra due Libri con l'inscrittioni
di fuori, ad uno Ptolonoei, & all'altro Vitellionis…nello specchio
le figure rette si riflettono, & perche questa scienza di luce retta,
& di riflessa servendosi, fa vedere di belle meraviglie, per tanto
in segno si è posto lo specchio. E risedendo le scienze nelli scritti
de famosi huomini, si sono dati à questa figura l'opere di due
Auttori onde tal scienza si rende ben manifesta…".
Il dinamico sistema spaziale è caratterizzato dalla convergenza
della composizione verso il lettore-fruitore, avente come asse, prospettico
e simbolico, l'unica figura posta di spalle, la Filosofia, madre
di tutte le arti. E' interessante notare come le numerose figurazioni
allegoriche di scienze ed arti esprimano, nella posizione e nell'atteggiamento,
il rapporto di collaborazione e complementarità rispetto ad essa.
(1) I termini astronomia ed astrologia furono praticamente usati come sinonimi per lungo tempo. Durante tutto il tardo Medioevo ed ancora nel Rinascimento la sinonimia continuò fino a che non fu adottata la distinzione tra l'astrologia sferica, che studiava i moti degli astri, e l'astrologia iudiciaria, che studiava invece i "giudizi" pronunziati dai corpi celesti intorno alle cose terrene. Quest'ultima, cioè la scienza degli influssi celesti e delle conseguenti norme per prevedere il futuro, fu condannata da Sisto IV con la bolla "Coeli et Terrae Creator" (in cui si proibivano anche usura e accattonaggio), condanna ribadita da Urbano VIII nel 1621. Nel corso del XVII secolo, dunque, l'astronomia, ormai scissa dall'astrologia, si trasformò da arte liberale in scienza, basata su esperienze e leggi fisiche, spogliandosi di quella componente mitica che l'aveva accompagnata per secoli.