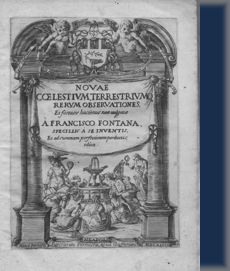cliccare sull'immagine per ingrandirla
supporto
cartaceo
oggetto: frontespizio
incisione calcografica
21x14
Il
portale, con timpano curvilineo spezzato, funge da "degno" ingresso
all'opera di contenuto astronomico. Nella parte superiore due putti alati
reggono uno stemma (con colomba e ramoscello d'ulivo) coronato da una
croce poliloba e da un cappello cardinalizio; stemma e copricapo si riferiscono
al dedicatario dell'opera, il cardinale Camillo Pamphili. I putti, inoltre,
reggono un lungo cartiglio in cui sono incise, in lettere corsive, alcune
parole desunte da un versetto dell'Antico Testamento (Quis enarrabit
coelorum rationem, Iob. 38), e il verso 4 del Salmo 146 (Qui numerat
multitudinem stellarum, et omnibus eis nomina vocat). Tra due colonne
corinzie si dispiega un drappo, posto in sostituzione della tradizionale
lapide, su cui sono stampati, in caratteri tondi e corsivi, il prolisso
titolo e il nome dell'autore del testo. Nella parte inferiore si svolge
l'ennesimo cartiglio su cui sono riportate le note tipografiche (luogo
e data di edizione; nome dello stampatore; licenza di stampa).
All'interno del portale numerose figure femminili, alcune delle quali
alate, sono disposte ad emiciclo intorno ad una fontana: le donne, accompagnate
da alcuni attributi iconografici e da scritte stampate su fasce che ne
cingono i fianchi e le spalle, sono personificazioni allegoriche di arti
e scienze. Grazie alle indicazioni provenienti dalla composizione e all'uso
della Iconologia di Cesare Ripa, è possibile riconoscere con certezza
ogni allegoria. Da sinistra: la Geometria, reca con sé un triangolo
e un compasso; la Matematica, una giovane
donna alata regge con la mano sinistra un globo terrestre, su cui sono
rappresentate le ore e i cerchi celesti, mentre con la mano destra impugna
un compasso col quale descrive una circonferenza su una tavoletta retta
da un fanciullo; la Cosmografia, i cui attributi iconografici non sono
riconoscibili; la Poesia, coronata d'alloro
e accompagnata da alcuni strumenti musicali; la
Filosofia, posta al centro dell'ideale emiciclo, di spalle: essa indossa
un vestito strappato in più punti e regge un libro; l'Architettura,
tiene fra le mani strumenti per la misurazione (filo a piombo, squadra,
asta graduata, etc.); l'Astrologia, una figura alata coronata di stelle,
indossa una veste stellata e reca con sé un globo celeste e un
libro aperto su cui sono rappresentati i simboli di alcuni pianeti; la
Prospettiva, regge con la mano destra uno specchio da cui emerge un volto,
con la sinistra un libro sul quale si intravede la scritta Ptolomoei.
Il Fontana, dunque, realizza un suo personalissimo "Parnaso"
in cui figurano alcune delle arti del Quadrivium (Matematica, Geometria,
Astronomia), una delle arti meccaniche (Architettura), una delle
arti care ad Apollo (Poesia), a cui si accompagnano, dato il testo di
carattere scientifico, la Prospettiva, ma soprattutto, la Cosmografia.
L'asse prospettico, ma anche simbolico della composizione, è rappresentato
dalla Filosofia, "madre di tutte le arti".