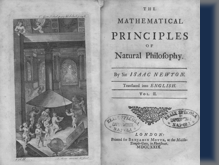cliccare sull'immagine per ingrandirla
Londra,
1729
I. Newton
supporto
cartaceo
oggetto: antiporta
incisione calcografica
19x12
Una
singolare tavola, incisa in rame, funge da ingresso alla versione settecentesca
del celebre capolavoro di Isaac Newton, The matematical principles
of natural Philosophy, edita a Londra, nel 1729.
L'opera fu pubblicata per la prima volta a Londra, nel 1687. Fu accolta
entusiasticamente in Inghilterra e in Olanda, mentre nel resto d'Europa
l'empirismo newtoniano fu avversato dal razionalismo imperante. Leibniz,
Bernoulli, Fontanelle e tanti altri furono, infatti, contrari al principio
di gravitazione, in cui vedevano un ritorno a "qualità
occulte", ormai superate. Solo più tardi, Voltaire e l'Illuminismo
compresero appieno il significato dell'opera di Newton. In essa, giunse
a compimento e trovò una coerente sistemazione, sia sul piano del
metodo sia su quello delle soluzioni, la rivoluzione scientifica iniziata
da Copernico e Galilei. Tale lavoro, così a lungo elaborato, era
destinato, non solo a fornire gli elementi essenziali del credo scientifico
e filosofico del XVIII secolo, ma anche a dare forma a quell'immagine
dell'universo e delle sue leggi, che è diventata patrimonio culturale
di noi tutti.
Per tornare all'incisione in antiporta, qui l'illustrazione occupa lo
spazio dell'intera pagina e fornisce immediatamente un'idea del contenuto
dell'opera. E' rappresentato l'interno di un vasto edificio, in cui si
riconoscono alcuni elementi di ascendenza classica, come la volta a lacunari,
le colonne sormontate da capitelli corinzi, le arcate a tutto sesto, che
si aprono verso un lussureggiante giardino; sul fondo di esso, si distingue
un edificio colonnato, sormontato da un timpano triangolare. In questa
sorta di tempio della scienza numerosi putti si muovono con disinvoltura
tra svariati strumenti scientifici.
Tra globi, compassi ed aste graduate, che ci introducono nella dimensione
scientifica dell'opera, è in corso un esperimento sull'oscillazione;
un putto, infatti, fa oscillare il peso, l'altro marca la corsa del pendolo
su un enorme strumento triangolare, l'ultimo trascrive attentamente i
risultati ottenuti su di una tavoletta.
Bilancia e pesi, inoltre, alludono evidentemente ai principi di quantità
di materia o massa e di forza gravitazionale rintracciabili
nel testo del fisico e matematico inglese.
L'intera composizione si inserisce perfettamente nel clima illuministico
della prima metà del Settecento; la libertà interpretativa
dell'incisore, infatti, non pregiudica l'esigenza di una documentazione
figurativa fondata su criteri rigorosamente oggettivi, tesi ad escludere
ogni possibilità di arbitrio. Abbandonate le opulente e complesse
soluzioni secentesche, dove sovente le immagini costituivano i veicula
privilegiati di una comunicazione quasi ermetica, lo scopo divulgativo-didattico
della nostra tavola si palesa nella rappresentazione dei putti, che conducono
l'esperimento newtoniano, in un clima sospeso tra le residue frivolezze
del Rococò ed una nuova "logica" compositiva orientata
in senso neoclassico.
Il generale risveglio della cultura, aspetto peculiare del Secolo dei
Lumi, e l'evoluzione del gusto, ormai tendente alla semplicità,
manifestatasi come reazione al Barocco, sembrano, dunque, costituire l'assunto
fondamentale cui l'incisore ha tenuto fede.