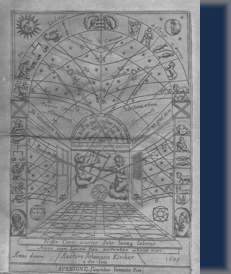cliccare sull'immagine per ingrandirla
Avignone,
1635
A. Kircher
supporto
cartaceo
oggetto: antiporta
incisione calcografica
22x16
Al
frontespizio tipografico, che introduce l'opera del padre gesuita, si
accompagna una complessa rappresentazione in antiporta dove il celebre
tedesco fece raffigurare lo schema dell'orologio astronomico-catottrico,
da lui costruito nella volta cilindrica della torre de la Motte per il
collegio gesuitico di Avignone; con esso, attraverso l'uso di specchi,
egli era riuscito a convogliare opportunamente la luce solare e lunare,
come deduciamo direttamente dalla rappresentazione. Sull'ideale parete
di fondo della spazialità virtualmente ricostruita, infatti, si
staglia la scritta "Horologium Aven= Astronomico Catoptricum Sic
Iesu in quo totius primi mobilis motus reflesco solis radio demonstratur".
Lungo le pareti laterali, inoltre, viene riportata la latitudine astronomica
della città francese: "Ad latitudinem Urbis Avenionensis
43 grad 30 m".
I raggi luminosi provenienti dal Sole e dalla Luna, posandosi sulle raffigurazioni
dei segni zodiacali, che corrono lungo l'arco d'ingresso della volta,
delle principali costellazioni e delle proiezioni uranografiche, tracciate
sulle pareti interne, indicano l'ora del giorno e quella astronomica.
Le figure senili e barbute alla base dello zodiaco, prive di attributi
iconografici che possano facilitarne l'identificazione, rappresentano
probabilmente due antichi astronomi, forse Aristotele e Tolomeo. I due
putti al centro della tavola, posti ai lati di una sfera armillare, sono
colti in atto di misurare le distanze stellari mediante il raggio astronomico,
uno strumento conosciuto sin da tempi molto remoti.
La difficoltà di comprensione relativa al funzionamento della meridiana
è espressa da una scritta in greco antico: "Nessuno che
non abbia conoscenze geometriche può comprendere". Il
motto che corona la volta (Sic luditur astris), infine, attribuisce
allo strumento scientifico una valenza anche ludica.
Dal punto di vista iconografico, il testo figurativo dell'antiporta, intervallato
dalla parola, che traduce l'immagine in espressione di una mistica delle
lettere oltre che dei numeri, sembra adeguarsi al gusto del secolo per
la teatralità. La funzione di "degno" ingresso propria
dell'antiporta, infatti, si riflette nella sua struttura compositiva a
volta cilindrica che, oltre a simulare il meccanismo dell'inconsueto orologio
solare, introduce il lettore-fruitore nella sostanza concreta del libro,
agevolandone la comprensione.
Il gesuita tedesco, per le sue numerose opere, ricorse spesso a frontespizi
ed antiporte gremiti di simboli e personificazioni allegoriche, che si
prestavano ad una elaborata decifrazione; per le immagini di corredo al
testo, invece, aveva l'abitudine di privilegiare quelle caratterizzate
da un taglio più essenziale e scientifico, che andavano ad accompagnare
un discorso verbale quasi sempre schematico e al limite della sommarietà.
Riguardo a tale abitudine è tuttavia opportuno focalizzare la nostra
attenzione su due riflessioni in particolare. Da una parte tale atteggiamento
è facilmente collocabile nella logica secentesca di una precisa
e oculata politica dei costi, che sfociò, poi, nel graduale scadimento
della veste tipografica e nel concentrarsi di ogni pretesa di bellezza
nelle parti più appariscenti del libro; dall'altra, esprime il
chiaro intento programmatico dell'autore che, collaborando attivamente
con i maestri incisori, si affidava al linguaggio grafico per veicolare
le proprie concezioni culturali, per sollecitare la curiosità del
lettore e rendere più appetibile un testo di non semplice comprensione
I frontespizi e le antiporte che introducono le opere kircheriane palesano
l'intervento dell'autore nella realizzazione dei disegni, che venivano
poi tradotti in semplici incisioni xilografiche o in più raffinate
incisioni calcografiche.
E' probabile che nelle opere di padre Kircher le immagini particolarmente
elaborate avessero la funzione di esprimere teorie "particolari",
che sconfinavano pericolosamente dal suo status di Miles Ecclesiae. A
conferma di ciò, possiamo citare, infatti, i suoi tentativi di
coniugare il cristianesimo con un neoplatonismo fortemente esoterico.